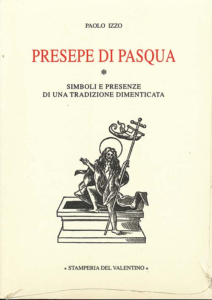
Manca davvero poco alla Pasqua, che a differenza del periodo antecedente al Natale, l’avvento, non porta con sé il clima festoso di una attesa, ma un tempo di riflessione e di preghiera, accompagnato da digiuno e penitenza, pratiche tipiche del periodo quaresimale. Tuttavia anche per la pasqua, così come per il Natale, nelle case e nelle chiese del quattrocento era consuetudine allestire il Presepe. Una rappresentazione che non si limitava solo alla raffigurazione della nascita del Cristo, così come dalla traduzione letterale dal latino di “praesaepe”, mangiatoia, ma che si estendeva anche alla Sua passione e morte sulla croce. Una riproduzione quindi lontana da quella ispirata a ciò che San Francesco fece a Greccio il 25 dicembre del 1223, di quanto San Luca Evangelista aveva riportato nel suo Vangelo, e cioè una figurazione vivente della sola nascita di Gesù, bensì una rappresentazione inanimata, catechetica, della vita di cristo, dall’annunciazione alla Vergine sino alla resurrezione. Una tradizione che la Controriforma, per una serie di motivi, abbandonò a favore della sola nascita, relegando l’altra a restare in vita all’interno dei monasteri. Tuttavia sono tante le chiese sparse su tutto il territorio nazionale e non solo, ad avere una rappresentazione catechetica della vita di Cristo, figurazione che molto spesso rappresenta il tempo compreso tra l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, sino alla morte e resurrezione. Accanto a questi allestimenti più o meno consistenti, le meno imponenti campane di vetro, con all’interno piccolissime, ma pregiate, raffigurazioni presepiali, gelosamente custodite nelle antiche abitazioni nobiliari. Una devozione popolare che ha subito nel tempo diverse mutazioni. Nei primi anni del cinquecento, infatti, San Gaetano Thiene, introdusse nel presepe inanimato alcuni personaggi del mondo contemporaneo. Una caratteristica peculiare che rendeva la rappresentazione della nascita di Gesù atemporale, ascrivibile così a qualsiasi epoca. È da questo tipo di raffigurazione che con molta probabilità ha preso vita la tradizione presepiale napoletana che ha aggiunto alla natività altre improbabili scene ricche di personaggi tratti dalla quotidianità partenopea. Una caratteristica che traslata ai nostri giorni ha visto, nelle botteghe di Via San Gregorio Armeno, statuine raffiguranti calciatori, politici e quanto altro poteva sprigionare la fantasia dei suoi artigiani. Un misto tra sacro e profano, ben lontano dalle raffigurazioni rinascimentali. Tuttavia nell’antica tradizione presepiale napoletana la figurazione catechetica della vita del Cristo è senza dubbio presente, e il volume “Il Presepe di Pasqua” di Paolo Izzo ne è una testimonianza. L’autore, infatti, in questo libro, compie un viaggio all’interno delle tante tradizioni che a Napoli hanno da sempre accompagnato la celebrazione della Pasqua, e i collegamenti tra le origini pagane e le celebrazioni cristiane. Oggi Il Presepe di Pasqua sembra essere tornato in alcune chiese, non certo come quello del Duomo di Muggia o come quello permanente di S. Nicola alla Carità, di, Napoli, dove piccole statuine animate descrivono la vita di Gesù, dalla nascita alla passione e morte sulla croce, ma con semplici istallazioni iconografiche o strutturali dell’Ultima Cena, della Passione e morte di Gesù. Un motivo in più per rispolverare questa pubblicazione oggi quanto mai attuale. Un testo che attraverso l’arte presepiale dà la possibilità, a chi non può materialmente recarsi in pellegrinaggio nei luoghi reali della Storia, di vivere ugualmente quell’emozione di grande significato spirituale.
Anna Di Fresco